
| Nuova Serie | ::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
|
| Anni 2005/2006 | ::
::
::
::
::
::
::
::
|
| Utilità | ::
::
::
::
::
::
::
|
|
|
Cultura
| 795 - CANDIDATI IN BIANCO |
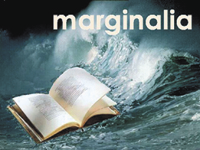
note di cultura mediterranea
a cura di Franca Giusti
« è sul margine di una pagina d’altri che ci si annota »
[Delfino Maria Rosso in www.gliannidicarta.it ]
CANDIDATI IN BIANCO
La corruzione politica nell'antica Roma era il risultato di un meccanismo per l' elezione dei consoli "di tipo uninominale". |
"I consoli erano due e la lotta si svolgeva tra pochissimi candidati che, per essere eletti, dovevano sostenere ingenti spese per la campagna elettorale. E fare molte promesse. Una sorta di voto di scambio e di malgoverno, volto a far prevalere l’interesse particolare su quello generale e al non rispetto delle leggi. Guardare la storia oggi e dire che il passato, gli antichi, il mondo greco romano era corrotto ed invivibile è utile per imparare dagli errori e progettare meglio il futuro.
Nel mondo greco, quello che Clistene, uno dei padri della democrazia, divise in dieci “tribù” allo scopo di ridurre la forza di alcuni antichi gruppi di potere, anche in quel mondo c’era la corruzione. Eppure era in dieci le parti al potere, non solo due.
Clistene cercò di inserire la popolazione nel processo decisionale della vita politica, ma le clientele precedenti rimasero ed in più si svilupparono altre e nuove forme di rappresentanza e cooperazione. A sviluppare le nuove rappresentanze, nel tempo furono i poveri che, pur essendo al servizio dei nobili, ebbero modo di ribellarsi tramite l’espressione di parola nell’assemblea popolare.
A descrivere cause e particolari della corruzione nonostante l’avvio del processo di democratizzazione, furono Plutarco e Aristofane, ciascuno a modo suo, ed entrambi concordano sull’abitudine dei potenti, persino di Pericle, a guadagnarsi il consenso del popolo organizzando banchetti e feste e impiegando il denaro dello Stato per creare monumenti ornamentali.
E’ un circolo, strettamente collegati e dipendenti, potere e denaro sembrano essere gli elementi ricorrenti nello scenario della politica del mondo antico. Un esempio è quello di Pericle che attribuì un’indennità giornaliera a quanti ricoprivano le cariche pubbliche, intervento che ridimensionò fortemente l’idea del servizio a favore del pubblico, dell’impegno gratuito per l’interesse pubblico. C’è un aspetto positivo in questa scelta. Offrendo un “gettone di presenza”, chiamiamolo così, anche le fasce più povere avrebbero potuto accedere alla politica, certo non come alternativa al lavoro ma per non dover essi stessi spendere denaro che non avevano. E’ lecito pensare che, almeno in qualche circostanza, sia stata una occasione di lavoro. Da lì alla vendita del voto, il passo fu breve e la politica divenne il più fertile terreno per la corruzione. E lo divenne di conseguenza il tribunale in cui i magistrati, in cambio di denaro, decidevano a chi assegnare la vittoria della causa, non curanti dell’innocenza o della colpevolezza dell’imputato. Accanto ai giudici, estratti a sorte tra i cittadini, anche i funzionari pubblici e amministrativi si lasciavano corrompere e corrompevano a loro volta, entrati ormai nella routine del sistema.
Nella Roma di Cicerone le cose non erano diverse. Proprio Cicerone elogiava i brogli elettorali di cui era accusato Catone, sostenendo che: “La piccola gente ha un solo mezzo, nei riguardi del nostro ordine senatorio, per guadagnarsi o ricambiare un beneficio: ed è codesto darsi attorno e starci attorno alle nostre campagne elettorali. […] Non voler dunque, o Catone, strappare a questa più umile gente questo frutto delle sue premure, e consenti ad essi, che tutto attendono da noi di aver qualcosa da offrici a loro volta. Se questo qualcosa sarà null’altro che il loro voto, è ben poca cosa, poiché votandosi per gruppi, non nasce da esso un titolo individuale di benemerenza […]”. Dal canto loro, Plauto e Sallustio affermavano che i poveri si erano messi “a vendere la propria libertà insieme con lo stato”. Si passò così dal voto segreto al voto palese ma nulla cambiò. Ci fu però una legge che tentò di arginare il fenomeno, la Lex Calpurnia, approvata da Lucio Calpurnio Pisone nel 149 a.C., che sanzionava i crimen
repetundarum, cioè estorsione, corruzione e captazione dei doni da parte di magistrati che li sottraevano alla comunità. Poi fu la volta della lex Iulia e poi di un mare di altre leggi e norme che negli ultimi duemila anni si sono aggiunte ed aggiornate sulla base dei regimi che si sono avvicendati, Repubblica, Impero o forme miste. Quello che, nel tempo, è cambiato e ci sono le prove, è il fatto che oggi, i candidati alle cariche pubbliche non indossano più vesti bianche come indossate dai candidati.

|
|

| Il giornale | ::
::
::
::
::
|
| Elia Finzi |

Tunisi 1923-2012
|
| Numeri recenti | ::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
|
|
